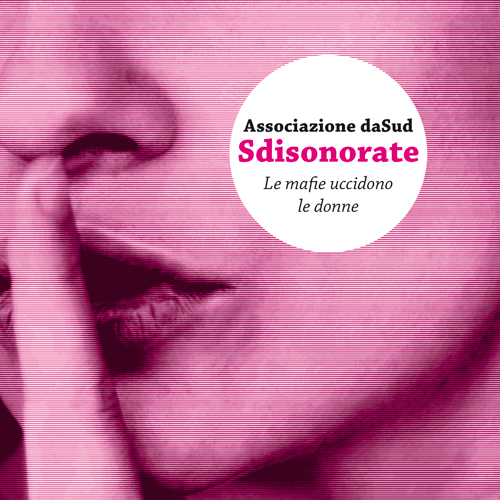Ci sono dei numeri che non fanno notizia. Sono tanti in Italia. Sono quelli dei morti sul lavoro, quelli delle vittime delle mafie, quelli indefiniti dei migranti annegati in mare. E poi ci sono quelli delle donne ammazzate: solo nel 2012 sono già arrivate 45. Di queste donne non si sa praticamente nulla: se ne parla poco e male. Ancora adesso autorevoli giornali, quando devono dare per esempio la notizia dell’ennesima ragazza uccisa dall’ex fidanzato, titolano “per motivi passionali” o “per gelosia”.
Se poi ci spostiamo in televisione la situazione peggiora notevolmente. Le trasmissioni di approfondimento politico non affrontano mai il problema come questione strutturale, ma mettono intorno a un tavolo le forze politiche soltanto davanti a una violenza “straordinaria” (caso Reggiani) determinando così un’attenzione esclusiva e mai di sistema. Il più delle volte vengono chiamate a discuterne solo le donne (meglio ancora se in occasione dell’8 marzo) come se fosse un problema che investe solo loro. Si mettono insieme donne di aree politico-culturali diverse: uno schema che serve a sostenere che, davanti alla violenza sulle donne, la battaglia è comune e non si fanno differenze fra destra e sinistra.
Come se affermare che la famiglia è il luogo in cui avvengono maggiormente le violenze o invece che la violenza si consuma per strada e per mano migrante sia la stessa cosa. Come se questo punto di partenza sia irrilevante nella costruzione di un’azione politica. Come se per sconfiggere la violenza non sia importante fare un’analisi corretta. Un’ipocrisia politica al femminile che in questi anni ci ha fatto fare passi indietro e non in avanti.
Peggio dell’approfondimento politico, ci sono i programmi di attualità caratterizzati dalla presenza di “opinionisti”. È lì che si consuma il male assoluto: la violenza diventa una soap opera durante la quale è possibile tirare fuori tutta l’ignoranza e la barbarie insita nella pancia del Paese. “Nessuno ha il diritto di togliere la vita ad un essere umano”, e fin qui ci siamo. Poi però si va a scavare nell’esistenza di lei, si definisce lui “un ragazzo che l’amava troppo”. E si va avanti rivolgendo al pubblico da casa domande del tipo: “Uccidereste per gelosia?”. Tutto affrontato con una leggerezza sconcertante come se non fossimo davanti a una morte reale, ma sempre dentro una fiction.
Anzi, in questo caso, la fiction andrebbe salvaguardata. È il caso, per esempio, della nuova miniserie tv “Mai per amore”, prodotta per la Rai dalla società di Claudia Mori, rinviata per mesi senza un perché nonostante sia un tentativo utile di far capire come la violenza non è una questione “romantica” o di “sicurezza”. La violenza è una questione politica e di sicurezza culturale.
E non essere ammazzate è una questione di forza o di fortuna. La forza è rappresentata dalle donne che denunciano i propri aguzzini prima che si arrivi all’atto definitivo, che è la morte fisica e psicologica. Ed è una forza vera: non è facile capire quello che ti sta succedendo e poi affrontare il contesto in cui portare avanti il tuo processo di liberazione sia dal punto di vista legale che sociale.
Proprio per questa ragione la politica dovrebbe vergognarsi dell’abbandono in cui lascia tante donne che decidono di fare questo percorso. Lasciare che chiudano i centri antiviolenza è essere complici di questo sistema. Non dare rappresentanza alle donne è essere complici di questo sistema. Non fare nulla per inserire le donne nel mercato del lavoro è essere complici di questo sistema. È tutto collegato. E la responsabilità della politica è enorme: non ha garantito nessuna tutela e ha peggiorato in maniera inconfutabile le nostre condizioni di vita.
È vero che la violenza – agìta e subìta – non conosce classe sociale, livello di erudizione, età e nazionalità. Ma è altrettanto vero che dentro questo meccanismo non si possono non rilevare azioni concrete che mettono sempre più a rischio la condizione femminile. La minaccia economica, per esempio, continua a essere uno degli strumenti più diffusi per non permettere alle donne di andare via. L’immagine svilita della narrazione politica del corpo delle donne, da sinistra a destra, ha accentuato e giustificato il comportamento di sopraffazione.
Una conferma di tutto questo ci arriva ancora una volta dai numeri: aumentano infatti le violenze fra le giovani generazioni e la maggior parte delle uccise quest’anno non aveva superato i 35 anni. In tempi di crisi, l’umanità che ci troviamo di fronte è un’umanità abbrutita, di sconvolgimento dei ruoli. Se da una parte lo stato di precarietà avvicina i ragazzi e le ragazze e li mette nelle condizioni di ragionare intorno ad un’idea indifferenziata di cittadinanza, dall’altra parte la condizione “nuova” per i giovani uomini di non rispecchiare il modello materiale del padre – il ruolo che gli è sempre spettato nella società – porta con sé un lutto senza elaborazione con dentro un grande carico di violenza. Oggi l’unica “cosa” che puoi possedere è un’altra persona.
E chi subisce non è così lontano da questa logica: forse ti convinci davvero di essere la “cosa” più preziosa, la “cosa” che può arrivare al punto di farlo impazzire. Ci tiene così tanto a te da perdere il controllo delle sue azioni. Chi ti ha mai desiderata così tanto? La dipendenza psicologica che si crea è talmente forte da non distinguere più il bene dal male, l’amore dalla violenza. È difficile per chi lo vive, difficile per chi ti guarda. Troppe volte ho sentito utilizzare espressioni del tipo: “Ma perché non se ne va?”, “Se la sta cercando”. Fino a quando questa dimensione non ce l’hai accanto a te o ti attraversa non riesci a capirla.
Come si spiega la paura? È consapevole e inconsapevole? Come ci si difende dalla violenza sociale di chi ti guarda e pensa che è colpa tua? Non sono interrogativi personali, non è una dimensione intimista: a queste domande dovremmo rispondere tutte e tutti, a queste domande dovrebbe dare una risposta – finalmente – la politica.
Nessuno di questi temi è neutro. Per questa ragione non può che caratterizzarsi a partire da qui oggi un soggetto politico di Sinistra. Quello di genere, della violenza maschile sulle donne non è un settore, non è e non deve essere un “dipartimento” dentro l’apparato di partito. Di più: non è nemmeno una commissione alle pari opportunità. Voglio fare un esempio concreto. La prima legge sullo stalking in Italia l’abbiamo avuta grazie al ministro delle Pari opportunità del Governo Berlusconi, Mara Carfagna. La battaglia cominciò nella XV legislatura ed era stata promossa dalle parlamentari del centro-sinistra, ha visto la luce da un Governo e da una donna di destra. Oggi, grazie a quella legge, le donne possono denunciare.
Ma questa vicenda e questo Governo ci confermano anche che la politica non è affatto neutra e che bisogna guardare alla complessità della politica delle donne e degli uomini. Perché è sempre lo stesso Governo Berlusconi, con Mara Carfagna in carica, ad avere rinserito le dimissioni in bianco, portato l’occupazione femminile ai minimi storici soprattutto al Sud, smantellato il diritto allo studio, demolito qualsiasi forma di welfare esistente. Ecco perché o le pari opportunità le concepiamo come azione che interviene in tutti gli ambiti dell’esistenza, oppure l’azione sarà sempre limitata a quella che in questo Paese viene considerata una vertenza di una parte e non di tutte e tutti. Noi che vogliamo fare?